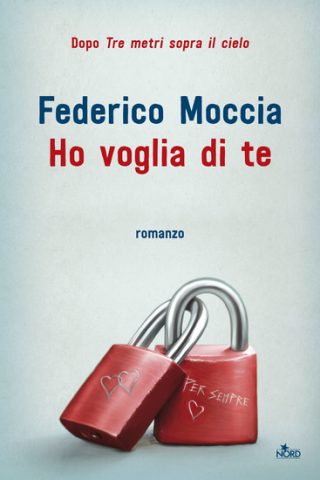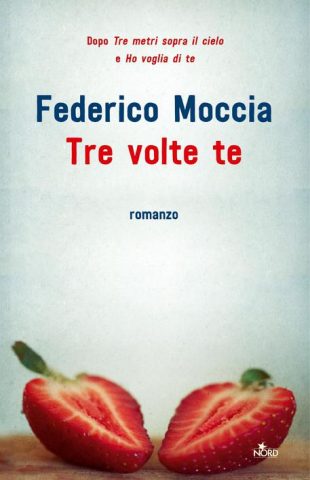di Trifone Gargano
Il romanzo Tre metri sopra il cielo, di Federico Moccia, uscì in prima edizione auto-prodotta nel lontano 1992, a Roma. L’autore, infatti, aveva incassato diversi rifiuti da (importanti) case editrici alle quali, da speranzoso giovane autore esordiente, aveva inviato in lettura il suo manoscritto.
Nel 2004, Feltrinelli, accortasi del successo “clandestino” del libro, decise di rilanciarlo a livello nazionale, sotto il proprio marchio, in una versione parzialmente ri-pensata dall’autore, dando così vita a un singolarissimo caso letterario, e anche a un vero e proprio fenomeno di massa, con il rito dei lucchetti, accentuati, l’uno e l’altro, dall’uscita, sempre nel 2004, dell’omonimo film del regista Luca Lucini (con un giovanissimo Riccardo Scamarcio, nel ruolo del protagonista maschile, Step).
Il remake spagnolo del film, Tres metros sobre el cielo, del 2010, fu pellicola record d’incassi. Federico Moccia, dunque, fu travolto da un’ondata di successo e di emozioni, anche molto al di là di come, forse, egli stesso si aspettasse, o sperasse che avvenisse, che modificò radicalmente la sua vita, e la sua stessa vocazione di scrittore, segnandole positivamente, negli anni successivi, e che, per molti versi, dura ancora, a distanza di quasi vent’anni dall’edizione Feltrinelli, e di quasi trent’anni dalla prima edizione auto-prodotta della storia di Step e Babi. Nel 2006, uscì il sequel del romanzo, Ho voglia di te; poi, nel 2017, a chiudere idealmente la trilogia, Moccia diede alle stampe Tre volte te.
Tre metri sopra il cielo racconta la storia di un “folle” innamoramento, tra due giovani dell’alta borghesia romana, zona nord di Roma, ambientata nei primi anni Ottanta: Babi Gervasi, studentessa presso una scuola privata, l’Istituto «Santa Giuliana Falconieri»; ragazza, ovviamente, bella e altezzosa; e Step, cioè, Stefano Mancini, giovanotto scontroso e problematico, che, dopo la separazione dei suoi, comincia a frequentare cattive compagnie.
Ricordo che, nel 2005, in un incontro pubblico di presentazione del romanzo, in un Liceo della provincia di Bari, con la partecipazione dell’autore, Federico Moccia, e alla presenza di centinaia e centinaia di giovanissimi studenti, tutti, ma tutti per davvero, lettori del romanzo, molti dei quali lo stringevano tra le mani, in adorante ascolto della parola di Moccia, in un auditorium stracolmo di gente, e carico di silenzio, quasi stesse accadendo un rito religioso, stupii tutti, a cominciare dallo stesso Moccia, come lui stesso dopo, in privato, mi confidò, per due ragioni: la prima, perché dichiarai di aver letto per intero il romanzo, e che il romanzo mi fosse piaciuto; la seconda ragione di generale stupore, stava nella mia affermazione successiva, e cioè che, in fondo, in fondo, quel (bel) romanzo di Moccia, ai miei occhi di eterno lettore e studioso di Dante, altro non fosse che la riscrittura di due ben precise scene della Commedia, l’una infernale, i lussuriosi travolti dal vento, che mai non resta; l’altra celestiale, i folli amanti del terzo cielo (quelli che Dante colloca tre metri sopra il cielo).
Dopo questa mia seconda affermazione, vieppiù, il silenzio cadde sull’auditorium. Si trattava del giudizio di un prof, che promuoveva il romanzo di Moccia, mentre, quasi tutti gli altri docenti d’Italia (con disprezzo) lo avevano definito romanzetto “di genere”, nelle loro recensioni, per liquidarlo, quindi, come (sotto)letteratura rosa e di consumo. Questo era il primo elemento dello scandalo: un docente che esprimeva giudizio critico di valore. Questo scandalo si ripeté, qualche mese dopo (lo rivelo, qui, per la prima volta), nell’ambito dei lavori di un convegno universitario, nel quale ero stato invitato come relatore, per parlare di lett-erat-ura a scuola; ebbene, in quel convegno, citai proprio, come esempio positivo, l’esperienza di lettura svolta sul libro di Moccia, che avevo seguito come docente, e di cui ero stato diretto testimone. Subito dopo il mio intervento, prese la parola un illustre docente universitario (oggi, in pensione), dell’ateneo romano, per tuonare sulla mia “buonafede”, e per ammonire i presenti (a partire da me) che certi autori non solo non andrebbero letti, ma che, in pubblico, non se ne dovesse pronunciare nemmeno il nome. Ovviamente, dissentii, nella brevissima replica concessami. Ma tutto finì lì.
Adesso, qui, mi interessa argomentare la mia ipotesi critica, che, a distanza di anni, giudico ancora tutta fondata, e cioè Tre metri sopra il cielo come esempio di ri-scrittura post-moderna di due scene della Commedia dantesca, celeberrima la prima, con Paolo e Francesca, «peccator carnali», meno nota la seconda, con Cunizza Romano, Folco da Marsiglia (noto anche come Folchetto), e Raab, luminosissime stelle del terzo cielo, il cielo di Venere.
L’amore tra Step e Babi, raccontato da Moccia, è un amore forte, carico di difficoltà. Babi, infatti, si farà trascinare in questo amore impossibile, colpa anche del «vento», che la colpisce e che la avvolge, allorquando si sistema sul sellino della motocicletta di Step, per seguirlo nel suo mondo pericoloso, senza alcuna regola, fatto di gare clandestine di moto, e di tante altre cosucce. La loro storia d’amore finirà, e finirà in malo modo, con una morte. Non rivelo tutta la trama del romanzo, così, chi non lo avesse mai letto, potrebbe sentirsi invitato a farlo adesso.
Il «vento» è parola concetto, sia in Dante, per i due «peccator carnali», che «insieme vanno», sia in Moccia, per la scena del primo passaggio in moto, offerto da Step a Babi, con i due ragazzi che, anche in questo caso, abbracciati, «insieme vanno»:
La moto parte veloce, con rabbia, scattando in avanti. Babi istintivamente lo abbraccia. Le sue mani finiscono, senza volerlo, sotto il giubbotto. La sua pelle è fresca, il suo corpo caldo nel freddo della notte. Babi sente scivolare sotto le sue dita muscoli ben delineati. Si alternano perfetti a ogni suo più piccolo movimento. Il vento le scorre lungo le guance, i capelli bagnati ondeggiano nell’aria. La moto si piega, lei lo abbraccia più stretta e chiude gli occhi. Il cuore comincia a batterle forte […], gira la faccia e posa la guancia sulla sua schiena, sempre senza guardare, lasciandosi cullare da quel salire e scendere, da quel rumore potente che sente sotto di lei.
[da F. Moccia, Tre metri sopra il cielo, Feltrinelli 2004, p. 62]
Farei notare, oltre a quelle già dichiarate, anche altre somiglianze, tra questa pagina di Moccia e il testo di Dante, come, per esempio, il dettaglio che il movimento della moto costringa i due giovani (amanti) ad abbracciarsi maggiormente (sballottolati esattamente come le anime infernali dantesche dei lussuriosi). Inoltre, l’espressione del «salire e scendere» dei due ragazzi («di qua, di là, di giù, di su li mena», v. 43), sulla moto, lanciata a velocità folle, nel «vento» della notte, del buio (un «loco», anche questo, descritto da Moccia, «d’ogne luce muto», v. 28). Dante, rivolgendosi a Virgilio, per definire l’ambientazione di questi dannati, «quelle / genti», utilizzerà proprio l’espressione «aura nera», v. 51. In abbinamento con il vocabolo «vento», anche Moccia, come già ha fatto Dante (v. 79), utilizza «piega».
In Dante, il vocabolo «vento» compare già nel verso 30 del canto V dell’Inferno, in una ambientazione di buio pesto («loco d’ogne luce muto»):
La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina;
voltando e percotendo li molesta. [vv. 31-3]
[…]
I’ cominciai: «Poeta, volentieri
Parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri»
[…]
Sì tosto come il vento a noi li piega,
mossi la voce […] (vv. 73-5 e 79-80)
Ma la riscrittura operata da Moccia non si limita soltanto a questo aspetto del celeberrimo episodio di Paolo e Francesca (la cui passione è rappresentata, in entrambi i testi, attraverso la forza del «vento»), no. Anzi, già dal titolo del romanzo, Tre metri sopra il cielo, evoca e rilancia il terzo cielo del Paradiso dantesco, che è, com’è noto, il cielo di Venere, quello degli spiriti amanti. A questi beati Dante dedica due canti del Paradiso, e precisamente, i canti VIII e IX. Proprio nel secondo verso del canto VIII del Paradiso, questi spiriti vengono definiti come «folli amanti». E cosa sono, in effetti, Step e Babi, se non due «folli amanti»?
L’espressione dantesca «folle amore» è nel canto VIII del Paradiso, cioè in uno dei due canti che Dante dedica al cielo di Venere, il terzo cielo, quello degli spiriti amanti, spiazzando i lettori del suo tempo, ma anche i lettori di oggi, per alcune sue scelte, come dire, «folli», visto che egli colloca tra questi beati ben tre personaggi che, in vita, si erano fatti notare per il rispettivo abbandono sfrenato e gioioso all’amore sensuale. In ordine di apparizione, questi tre rappresentanti del «folle amore», del quale, come precisa Dante, non si pentono, sono Cunizza Romano, Folco da Marsiglia e Raab. I primi due, Cunizza e Folco, sono personaggi medievali, vicini dunque cronologicamente a Dante, e ai suoi primi lettori. Il terzo personaggio, che luce in questo terzo cielo, è Raab, prostituta di cui narra la Bibbia, che aiutò il condottiero Giosuè a conquistare l’altrimenti inespugnabile città di Gerico. Di lei, Dante scrive che, in questo terzo cielo, «si sigilla», brilla, in «sommo grado». Per quanto riguarda gli altri due esponenti del «folle amore», Cunizza pronuncia versi solenni e perfetti di auto-assoluzione, tra i più memorabili della Divina Commedia:
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse mi vinse il lume d’esta stella;
ma lietamente a me medesma indulgo
la cagione di mia sorte […] (Pd., IX, 32-5)
Invece, Folco da Marsiglia fu poeta trovatore tra i più importanti, morì nel 1231, autore di notissimi componimenti d’amore, dedito, in gioventù, al libero amore (ma, in tarda età, si convertì e si fece monaco, fino a ricoprire la carica di vescovo di Tolosa, e, addirittura, fino a promuovere la crociata contro gli albigiesi). Dante chiarisce che, in questo terzo cielo, nessuno dei beati soffre per ciò che in vita ha commesso (il «folle amore», appunto), anzi, ne gode («ride»), perché anche la loro sfrenata inclinazione all’amore sensuale, in vita, era stata voluta e determinata dall’influsso del terzo cielo:
Non però qui si pente, ma si ride,
non de la colpa, ch’a mente non torna,
ma del valor ch’ordinò e provide (Pd., IX, 103-05)
Con parole simili, anche Cunizza aveva espresso analogo giudizio di auto-assoluzione:
perché mi vinse il lume d’esta stella (Pd., IX, 33)
La responsabilità della mia vita giovanile, che fu sfrenata, sostiene cioè Cunizza, per quanto riguarda l’inclinazione all’amore sensuale, non è mia, ma di questo terzo cielo, che «mi vinse». Si narra, infatti, che Cunizza, a un certo punto della sua vita, fu rapita (nel senso che fu liberata) dal poeta Sordello da Goito, nella città di Verona, dove Cunizza si trovava “prigioniera” del marito, tal Rizzardo di San Bonifacio, signore della città. Con Sordello, Cunizza visse una intensa storia d’amore, per poi lasciarlo, e correre, liberamente, verso altri amori, e altri matrimoni.
Di Raab, infine, notissima prostituta e meretrice, Dante scrive parole luminose, già nella presentazione (per bocca del poeta Folco da Marsiglia):
Tu vuo’ saper chi è in questa lumera
che qui appresso me così scintilla
come raggio di sole in acqua mera.
Or sappi che là entro si tranquilla
Raab […] (Pd., IX, 112-16)
Insistendo, in soli tre versi, su vocaboli legati alla sfera semantica della luce: «lumera – scintilla – raggio – sole».
In conclusione, dunque, come non assolvere anche Step e Babi, per questo loro «folle amore», anch’essi tre metri sopra il cielo, cioè, sotto l’influsso del terzo cielo, quello di Venere e dei «folli» amanti?
Per chi volesse approfondire:
- testo del canto V dell’Inferno (per Paolo e Francesca):
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Inferno/Canto_V
- testo del canto VIII del Paradiso (nel cui secondo verso si trova l’espressione «folle amore»):
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Paradiso/Canto_VIII
- testo canto IX del Paradiso (per Cunizza, Folco e Raab):
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Paradiso/Canto_IX