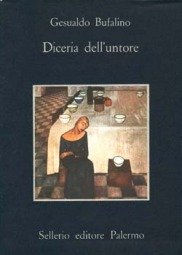a cura di Trifone Gargano
Questo romanzo di Gesualdo Bufalino (1920-1996) ha avuto una lunga gestazione. L’autore, infatti, cominciò a scriverlo nel 1950, per poi riprenderlo nel 1971, e pubblicarlo, infine, nel 1981. “Diceria dell’untore” ebbe subito, appena pubblicato, un grande e unanime successo, sia di critica, che di pubblico (in quello stesso 1981 vinse, infatti, il prestigioso Premio Campiello).
Innanzitutto, stupì l’esordio tardivo di questo scrittore siciliano, che, per tutta la vita aveva svolto la professione di docente, e che si era sempre dichiarato riluttante a pubblicare, nonostante gli inviti e le amichevoli pressioni di Leonardo Sciascia e degli editori Sellerio, a tirar fuori dai cassetti le sue opere. Nel 1981, dunque, si convinse a farlo, e diede alle stampe la sua Diceria, un’opera totalmente al di fuori dei canoni e degli stili narrativi dominanti nell’industria editoriale italiana di quegli anni (e, quindi, anche nei gusti dei lettori). Non a caso, infatti, l’editore Sellerio era un piccolo editore di periferia, siciliano, appunto, come lo stesso autore. Fu tale il successo di questo libro che, pochi anni dopo, nel 1990, fu realizzato un film, con la regia di Beppe Cino, e con Remo Girone, Lucrezia Lante della Rovere e Franco Nero tra gli interpreti (per citare solo qualcuno).


La trama del libro era come sospesa, a metà, tra l’estasi e la pena; il melodramma e l’ironia. E poi, stupiva in questo esordiente di sessantun anni la scrittura, la lingua, anch’essa come sospesa, a mezz’aria, tra la prosa e la lirica; la comunicazione e la ricercatezza retorica; l’ingenuità e la malizia. “Diceria dell’untore” narra di un amore fra due ammalati, un amore di sanatorio, con ambientazione negli anni del secondo dopoguerra. Nell’estate del 1946, infatti, un reduce è costretto ad affrontare, dopo il dramma della guerra, un’altra sfida della morte, nel sanatorio della Rocca, sulle alture della città di Palermo. Lì troverà, tra gli altri ricoverati, alcuni reduci come lui. Tutti i ricoverati si trovano nella condizione di essere per così dire “sospesi”, tra la vita e la morte. Essi, tutti, protagonista compreso, sono appesi alle prognosi del medico del sanatorio, un nobiluomo conosciuto come il «Gran Magro», che ha con il protagonista un rapporto privilegiato, per la semplice ragione che il giovane protagonista è l’unico disposto ad ascoltare tutte le sue «empiaggini». La vicinanza con la morte alimenta in questi malati la predisposizione a sviluppare meditazioni e riflessioni filosofiche. Singolare la vicenda di padre Mariano, che, nel tentativo di convertire alla fede il protagonista, finirà, lui, per restare contagiato dallo scetticismo del giovane.
Alla Rocca, in sanatorio, «l’attesa della morte è una noia come un’altra». Il Gran Magro, il medico della struttura, distrae i ricoverati proponendo e allestendo spettacoli di arte varia, con il coinvolgimento attivo degli stessi pazienti. In uno di questi improbabili spettacoli, precisamente, nel numero di danza di «aerea scrittura», si esibisce Marta Blundo, una giovane di appena vent’anni, che, nel suo aspetto diafano fa pensare a un serafino, con la «corta chioma di luce». Colpito da quella visione serafica, il giovane protagonista invita la ragazza a uscire con lui. Il Gran Magro, però, che si è accorto di tutto, gli ordina di star lontano dalla donna. Il protagonista apprende, così, che la tisi di Marta è terminale, e che la ragazza ha addirittura danzato al Teatro alla Scala, a Milano, come pure, viene a sapere che è stata l’amante di un ufficiale tedesco, e che, quindi, successivamente, una volta saputa la cosa, ha subito la rasatura integrale, che era il trattamento di sfregio che veniva riservato ai collaborazionisti (con nazi-fascismo). Ciò nonostante, il giovane sente nascere e crescere dentro di sé una incontenibile passione per la ragazza.
Rifugiatosi per qualche giorno di vacanza nel suo paese, il giovane capisce, facendone esperienza, che è «difficile stare morti fra i vivi». Rientrato, dunque, alla Rocca, luogo che, oramai, sente come suo, e al quale si sente irrimediabilmente di appartenere, riesce finalmente a contattare la ragazza, e, addirittura, a incontrarla in città, nelle ore libere. Marta gli racconta di sé, con qualche ambiguità e con qualche (imbarazzante) reticenza, come, per esempio, quando racconta delle «carezze di vecchio» del medico, il Gran Magro. A un certo punto, i due decidono di fuggire, utilizzando un’autovettura, e dirigendosi verso i paesi del palermitano. Si tratterà di una fuga disperata. La donna vivrà l’esperienza del congedo definitivo; il giovane, invece, che sente dentro di sé i segni della guarigione, dovrà affrontare, ancora una volta, lo scontro tra la vita e la Storia (nello specifico, assisterà a un corteo di contadini diretti all’occupazione di un feudo). Marta morirà in un alberghetto, e il giovane apprenderà, da freddi documenti, che il vero cognome della ragazza fosse Levi, cioè un cognome ebraico, con tutto il carico di tragicità che questo dettaglio getta sulla già infelice e tristissima storia della sua sfortunata compagna.
Anche il Gran Magro morirà (come, del resto, tutti gli altri ricoverati). Si salverà, dunque, solo il protagonista, con un soffocante senso di rimorso, per questa sua sopravvivenza. Egli sa, infatti, che ora lo attende il tempo ordinario, il tempo tristissimo dei giorni quotidiani, durante i quali trascinarsi. La guarigione ha, dunque, il sapore acre di una caduta, dalla quale egli potrà riscattarsi soltanto testimoniando al mondo di quella pietà, grazie proprio a questa sua diceria.